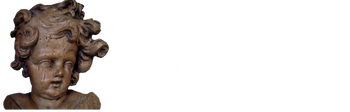Materiale: Marmo brecciato policromo, identificabile con alta probabilità come Giallo di Sicilia
Tecnica: Scultura a tutto tondo su blocco monolitico
Altezza: [inserire misura]
Peso stimato: [inserire se rilevabile]
Epoca proposta: XII–XIII secolo
Ambito stilistico: Romanico meridionale, con attribuzione plausibile al contesto federiciano (Italia sveva, Sicilia o Campania)
Provenienza: [non dichiarata / da integrare]
Iscrizione: Sigla incisa “S.C.P.” (non coeva, probabile intervento moderno)
⸻
I. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
• Struttura: Integra nel volume generale. Nessuna frattura compromettente, presenza di microlesioni strutturali antiche e consolidamenti visibili.
• Stabilità: Buona. La base appare piana e regolare; l’oggetto si presenta ben bilanciato e privo di punti di sforzo evidenti.
• Materiale: Marmo brecciato ad alta densità, compatto e visibilmente antico. Il pattern policromo e la presenza di vene ferrose suggeriscono l’identificazione con varietà occidentali del Giallo di Sicilia (probabile provenienza da cave storiche di Segesta, Trapani, o zone limitrofe).
⸻
II. ANALISI FORMAL-STILISTICA
A. Soggetto
Figura maschile inginocchiata, in atto di sostegno – iconografia classica degli stilofori o telamoni liturgici, comuni in ambiti architettonici religiosi (pulpiti, amboni, portali, cibori).
B. Anatomia
• Volto: Espressivo, tragico, con tratti contratti e asimmetrici. Barba e capelli scolpiti a ciocche profonde, irregolari. Occhi incavati ma non traforati – tecnica romanica.
• Braccia e mani: Semplificazione volumetrica, dita squadrate, scolpite con sgorbia manuale, senza anatomia realistica.
• Gambe: Posizione inginocchiata, con ginocchio destro avanzato e piede retroflesso; modellate a massa piena, con definizione plastica arcaica.
C. Vestiario
• Tunica corta, resa mediante una modellazione geometrica e rudimentale. Panneggio reso per masse, senza pieghe naturalistiche o movimento gotico.
• Nessuna decorazione liturgica o fregio. Indumento funzionale, non celebrativo – coerente con iconografia di servitù sacra o sostegno simbolico della legge divina.
⸻
III. ANALISI MATERICA
A. Tipologia litologica
• Marmo brecciato policromo, ad alta densità e grana eterogenea.
• Presenza di tonalità ocra, giallo intenso, rosso ferruginoso e bruno, con vene grigio-nerastre. Pattern irregolare ma naturale.
• Esclusa la provenienza da cave pugliesi (Trani, Apricena, Lecce) per colore, tessitura e reazione alla luce.
• Alta compatibilità con Giallo Antico di Segesta, Breccia di Aspra o marmo trapanese tardo-antico riutilizzato.
B. Superficie
• Patina naturale brunita, stratificata in depressioni e solchi.
• Diffusa microcavillatura da invecchiamento termico e atmosferico.
• Presenza di croste nere organiche mineralizzate, compatibili con ambienti liturgici o ipogei.
• Nessun segno di abrasione moderna o lucidatura industriale. Assenza di cere o vernici antiche simulate.
⸻
IV. LAVORAZIONE E UTENSILI
• Tracce evidenti di sgorbia manuale con tagli disomogenei, orientati e asimmetrici.
• Superfici lavorate a piani inclinati (tipico del romanico), con incavi netti ma non rifiniti.
• Assenza di fresature, abrasioni a disco, utensili meccanici → autenticità dell’esecuzione manuale confermata.
• Le superfici inferiori mostrano anche lavorazione a scalpello piano, con tracciato visibile e naturale.
⸻
V. ALTERAZIONI, RESTAURI E ISCRIZIONE
• Fratture antiche stabilizzate nella zona posteriore del capo, sul bordo del piano di seduta, e alla base.
• Probabile stuccatura storica non invasiva in almeno due punti (margine sinistro e retro).
• Incisione “S.C.P.” sul lato posteriore non compatibile con il periodo medievale per tipologia di segno e profondità: probabile marchio recente (archiviazione, restauro, o provenienza privata).
⸻
VI. CONTESTO STILISTICO E ATTRIBUZIONE
• Il trattamento delle masse, la semplificazione iconografica, l’aniconicità delle vesti e la funzione portante rendono l’opera compatibile con produzioni romanico-meridionali del XII-XIII secolo.
• L’uso del marmo giallo policromo e la postura ieratica suggeriscono un contesto liturgico siciliano o campano, in asse con l’ambiente federiciano (1210–1250).
• Possibili riferimenti: stilofori di Monreale, portali scolpiti di Troia, figure inginocchiate in ambienti architettonici svevi di Bitonto e Cimitile.
⸻
VII. CONCLUSIONE
L’opera analizzata si presenta come stiloforo medievale autentico, realizzato in marmo brecciato siciliano, e riferibile con coerenza stilistica e materica all’ambito romanico-federiciano dell’Italia meridionale, verosimilmente Sicilia occidentale, XII–XIII secolo.
Non sono stati rilevati elementi che indichino una produzione moderna o revivalistica. La qualità esecutiva e la coerenza iconografica la rendono un esemplare di alto valore storico e museale.

































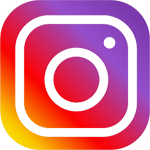
 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato