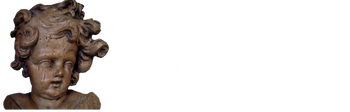Faustino Bocchi (Brescia, 1659 – 1741)
La guerra dei pigmei
Olio su tela, cm 45,5 x 61
Con cornice, cm 64 x 78
Questa peculiare e stravagante rappresentazione di una guerra fra pigmei, all’opera artistica del pittore bresciano Faustino Bocchi (1659-1741). L’estrazione lombarda di questo artista spiega solo parzialmente la scelta di raffigurare questo genere di opere che si inseriscono appunto in quel filone di sperimentalismo bizzarro e fantasioso di cui il Bocchi, l’Albrici suo allievo e, facendo un balzo indietro, l’Arcimboldo fanno certamente parte. L’altra grande influenza che si coglie è quella proveniente dai fiamminghi attivi in Italia nel corso del Seicento, alcuni dei quali si specializzeranno nella rappresentazione delle cosiddette bambocciate, ovvero opere che puntavano a raffigurare scene di vita quotidiana di stampo popolare, ambientate nelle taverne, nelle feste campestri o nei mercati cittadini. A differenza però degli aderenti alla scuola fondata da Pieter van Laer, il Bocchi non ha alcun fine realistico e decide di riempire le proprie opere di queste figure minuscole, definibili come nani o appunto pigmei, intenti a combattere, festeggiare o azzuffarsi nei modi più fantasiosi e impensabili, dando così alle scene un tono umoristico e burlesco. Il motivo bellico invece proviene da un conterraneo del Bocchi, ovvero Francesco Monti, detto il Brescianino delle Battaglie (1646-1703), specializzato nelle scene di battaglia appunto ma anch’egli legato al genere delle bambocciate. Ulteriori connessioni con le Fiandre si hanno invece attraverso Angiolo Everardi, allievo diretto del Monti e di famiglia fiamminga, grazie al quale il Bocchi si avvicinò ai generi della natura morta e soprattutto delle scene di genere. La minuziosità, i dettagli, le scene grottesche divennero marchi di fabbrica del Bocchi, da molti critici avvicinato, per fantasiosità, meticolosità nei piccoli particolari e bizzarria a Hyeronimus Bosch. Pur non essendoci un contatto diretto con le opere del maestro fiammingo, vissuto per altro più di un secolo prima del Bocchi, gli studiosi hanno individuato un sottofondo comune nell’interpretazione dei vizi umani attraverso creature buffe e stravaganti; se in Bosh questo messaggio appare evidente nel pittore bresciano va ricercato con una lettura più profonda, poiché le scene sembrano essere più prossime a un gusto favolistico e burlesco più che moraleggiante e religioso, trovando tangenze con i racconti della poesia comica italiana. Lo stile è immediatamente riconoscibile, come pure il soggetto, di cui esiste un originale del Bocchi, oggi in collezione privata, che ricalca la stessa composizione con la lucertola, le forbici, il banchetto e lo sfondo con il fiume e la torre. Sebbene i colori siano qui meno sfumati e più chiari e le linee di contorno siano più marcate ed evidenti, i personaggi e l’intera composizione sono eseguiti con pedissequa fedeltà.










































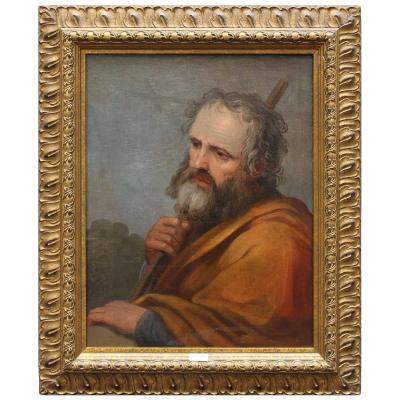



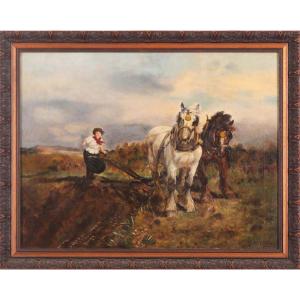



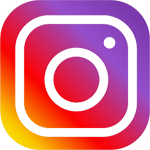
 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato